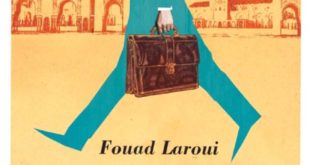Da dieci giorni i due ragazzi, fratello e sorella, erano nascosti nell’angusto sottotetto della loro casa. Il quartiere, nel frattempo, era stato sfollato e i soldati avevano perquisito casa per casa, deportando tutti, uomini, donne e bambini. I loro genitori avevano appena fatto in tempo a nasconderli nel sottotetto con le provviste di cui disponevano, riempiendoli di raccomandazioni per affrontare la difficile prova che li attendeva.
Il papà, prima di consegnarsi ai soldati, li aveva rassicurati con parole di speranza ma solo per tenerli buoni. Aveva gli occhi lucidi, la barba lunga di parecchi giorni, lo sguardo serio, come può esserlo quello di un padre convinto di non rivedere mai più i propri figli.
Lui e la mamma, per evitare la perquisizione della casa, si sarebbero consegnati ai militari, mentre loro dovevano restare nascosti per tutto il tempo necessario. Solo quando fossero stati sicuri di potere uscire, senza rischiare di essere catturati e deportati nei campi, dovevano fuggire e tentare di raggiungere alcuni parenti che vivevano in un altro villaggio.
Da quel giorno i due ragazzi non avevano mai lasciato il sottotetto, la loro nuova casa. L’odore degli escrementi, richiusi in una grossa latta chiusa da un coperchio di plastica, saturava il piccolo ambiente, ma il padre era stato categorico a riguardo: per nessun motivo, neanche per espletare i bisogni corporali e lavarsi, dovevano lasciare il nascondiglio, altrimenti il suo sacrificio e quello della mamma sarebbero stati inutili. 

Non era passata notte senza che i rumori dei mezzi militari li avessero tenuti svegli e all’erta, col terrore di vedere spuntare l’elmetto di un soldato dalla piccola botola che costituiva l’unico ingresso del nascondiglio. A volte i soldati erano così vicini da poterne sentire le voci e comprendere i loro discorsi. Spesso, al buio, si sentivano colpi di arma da fuoco, grida e lamenti. I momenti peggiori arrivavano quando i rumori finivano e tornava a regnare un cupo silenzio ma saturo ancora degli echi delle grida di quelli che non ce l’avevano fatta. Era quasi un sollievo al sorgere del sole, ascoltare il frastuono, ormai familiare, del quartiere militarizzato. Nel trambusto rassicurante del mattino i ragazzi riuscivano dormire per qualche ora. Il fratello più grande teneva tra le braccia la sorellina di cinque anni, stringendola da dietro, distesi sulle assi di legno di quello che una volta era stato il soffitto del soggiorno. In quel modo riusciva a rassicurarla e allo stesso tempo a riscaldarla. La bambina piangeva spesso ed era stato duro in quei giorni abituarla a farlo in silenzio, obbligandola a trattenere i singhiozzi e permettendo solo alle lacrime, silenziose, di scivolare e bagnarle le guance e il collo. Il ragazzo le asciugava con il bavero della giacca lurida, ansioso di piangere a sua volta, in silenzio, non appena la bimba si fosse addormentata. La mattina del decimo giorno, furono svegliati dai rumori insoliti provenienti dall’appartamento, proprio sotto i loro piedi. Alcuni militari erano entrati in casa e stavano spostando mobili e suppellettili. Il ragazzo capiva abbastanza la loro lingua per comprendere che la casa era stata scelta come dormitorio per alcuni ufficiali. Da quel momento in poi il silenzio e la cautela dovevano essere ancora maggiori. Prese tra le mani il viso della sorellina per sussurrarle all’orecchio come si sarebbe dovuta comportare. La bimba fece di sì col capo mentre le lacrime ricominciarono a scendere silenziose, bagnando le mani del fratello che non osava lasciarla.
Quella sera quattro uomini presero dimora nel loro appartamento e trascorsero la serata mangiando carne in scatola e fumando una sigaretta dopo l’altra. Il ragazzo, dal suo nascondiglio, li sentiva parlare, attento a non togliere mai le mani dalla bocca della sorella;
– Quanti ne abbiamo beccati oggi Maggiore?
– Non so, mi pare sei in tutto, in due appartamenti, pochi isolati più avanti. Tre li abbiamo trovati noi, se ne stavano rintanati in un buco sotto il pavimento della camera da letto.
– Come avete fatto a trovarli?
– La puzza, pivello! Dopo tanti giorni chiusi in quel buco, la puzza di merda si sentiva a miglia di distanza. E’ bastato seguirla ed eccoli li, mamma, papà e figlioletta.
– Immagino la faccia che hanno fatto!
– Sembravano topi in gabbia. Il padre si è buttato avanti per impedirci di prendere le donne ma non si reggeva neanche in piedi. Si è preso il calcio di un mitra sul muso ed è svenuto subito. Ci è toccato trascinarlo di peso fino al camion; non hai idea di come puzzava!
– E le donne?
– La bimba era piccola e la madre inguardabile. Facevano pena, non hanno mai smesso di piangere. Le abbiamo caricate sul camion e stop.
Il ragazzo continuava ad annusare l’aria cercando di capire se la puzza del loro nascondiglio potesse arrivare fino ai nasi dei soldati, poco più in basso. Non immaginava che l’odore tendeva a salire e a infiltrarsi tra le assi del tetto e quindi difficilmente sarebbe arrivato nella stanza di sotto. Il padre aveva scelto il nascondiglio con cura. Aveva preferito il sottotetto al vano sotto il pavimento del soggiorno, pur essendo in quest’ultimo gli spazi decisamente più ampi. Il padre era un ingegnere e sapeva il fatto suo, anche se, da quando era iniziata l’occupazione, non gli avevano più consentito di esercitare la professione e si era dovuto adattare a svolgere lavori manuali e sottopagati.
I soldati sdraiati sui letti, che una volta erano stati i loro, continuavano a parlare e a fumare;
– Maggiore, secondo lei perché questi bastardi non si convincono a farsi deportare in buon ordine?
– Credono che questa sia la loro terra, non accettano di perdere i loro privilegi, di essere cacciati e deportati altrove.
– In effetti loro qui ci sono nati!
– Non dire idiozie. La nostra sicurezza dipende dal consolidamento dei confini. Dobbiamo costruirci il nostro “spazio vitale”.
– Certo Maggiore, ma al loro posto anche noi avremmo combattuto.
– Tu non capisci Tenente? Noi siamo la razza superiore, una razza pura e non possiamo mescolarci con questa feccia di pezzenti, sottosviluppati e malaticci; nessuno ha diritto di ostacolarci.
– Io, comunque, al posto loro, non lo capirei!
– E’ per questo che esistono i campi, imbecille. Li rinchiudiamo lì, ognuno con i propri simili. Noi ci prendiamo la terra e le case e loro, ben chiusi, avranno modo di riflettere sul futuro che li aspetta.
– Però un po’ mi dispiace per quei poverini; in fondo non hanno fatto niente di male e nei campi non se la passeranno tanto bene.
– Tu non capisci nulla tenentino sentimentale dei miei stivali. Ci stiamo solo prendendo la rivincita dopo anni di oppressione e sofferenze. Dobbiamo liberarci di tutti quelli che occupano abusivamente il nostro territorio e allo stesso tempo dobbiamo espanderci. Solo così potremo proteggere i nostri confini e il nostro popolo. I campi servono solo per evitare che si disperdano, li rinchiudiamo e ce li teniamo fintanto che consolidiamo il nuovo ordine nei territori occupati, non gli succederà nulla di male, stai tranquillo.
Nel silenzio della notte, dopo che i soldati si furono addormentati il ragazzo, sempre tenendo stretta a sé la sorellina, cerco di rilassarsi e chiuse gli occhi. Sentiva il bisogno di svuotare la vescica ma non osava muoversi. Avrebbe aspettato che i soldati fossero usciti, la mattina dopo. Chiuse gli occhi e magicamente il sonno lo accolse tra sue braccia, inaspettato. Dormì a lungo, un sonno privo di sogni, vuoto e finalmente ristoratore. Fu svegliato dai rumori provenienti dalla stanza di sotto. Un soldato aveva svegliato gli ufficiali recando ordini. Il Maggiore lesse il dispaccio e annunciò con voce marziale di abbandonare il villaggio, le operazioni di rastrellamento erano terminate e si tornava alla base. Un evviva accompagnò le sue parole. Gli uomini raccolsero le loro cose e si precipitarono fuori. Tutta la mattina fu contrassegnata dal rumore dei camion militari carichi di soldati in partenza. Il ragazzo approfittò del rumore per svuotarsi e così fece anche la sorellina. Le fece mangiare alcuni biscotti, il fondo della loro scorta alimentare, e un sorso d’acqua. La bambina aveva la fronte che scottava e gli occhi lucidi ma lui non poteva fare altro che tenerla stretta e cercare di riscaldarla. Stettero abbracciati fino a sera. Il silenzio, quella notte, non fu interrotto da alcun rumore. Partiti i soldati il villaggio era popolato solo dal ricordo degli abitanti che non c’erano più. Quando la sorella si fu addormentata decise che era arrivato il momento per uscire. Aveva bisogno di viveri e di medicine. Nel comò dei genitori trovò alcune pasticche per abbassare la febbre e per la prima volta, dopo tanti giorni, un sorriso comparve fugace sulle sue labbra. I soldati avevano dimenticato alcune razioni di cibo, biscotti e scatolette. Le prese e le mise in un sacco, poi decise di scendere in strada. Aprì lentamente la porta e si guardò intorno per essere certo che nessuno degli occupanti si fosse nascosto per cercare di catturarli con un subdolo stratagemma. Quando si sentì sicuro si incamminò rasentando i muri e tentando di arrivare alla piazza del villaggio.
Il silenzio era interrotto solo dal rumore del vento che spostava stracci e fogli sparsi nel mezzo della strada.
– Non ti muovere o ti taglio la gola!
Il ragazzo si bloccò cercando di rimanere immobile ma le tempie gli pulsavano e il cuore batteva così forte da scuotergli il petto e le spalle. Il pensiero corse alla sorellina, sola e malata, nascosta nel sottotetto. Cosa ne sarebbe stato di lei adesso che lui era perduto?
– Girati e alza le mani!
Si girò lentamente tenendo gli occhi bassi e le mani alzate. Le lacrime gli rigavano le guance e sentì che le forze lo stavano abbandonando. Alzò lo sguardo verso quello che, era sicuro, sarebbe stato il suo carnefice, ma vide solo un ragazzo come lui, dai capelli neri e i vestiti laceri e sporchi. In mano aveva un vecchio coltello da cucina. Le guance erano smunte e gli occhi lucidi, lo sguardo spaventato quanto il suo.
– Chi sei tu?
– Io mi chiamo Omar, sono figlio di Mohammed Al-qaseer, sono palestinese!
di Michele Signa
 ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.
ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.