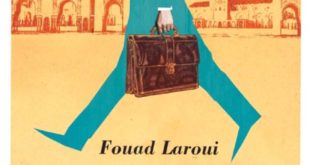(Prima parte)… La folla, il mostro orribile che è diventata la massa, rivela gli istinti animaleschi del popolino. «Prima volevano le carni della baronessa, le carni fatte di pernici e di vin buono»: non occorre scomodare Freud per renderci conto di che cosa significhi questo passaggio. Si può avanzare un’ipotesi, forse banale: al di là dell’invidia, gli umori bassi del popolo mirano a soddisfare le loro bramosie sessuali: la baronessa è il modello femminile desiderato, la nobildonna in salute che le classi subalterne figurano come massima espressione del gentil sesso. Andando oltre, si pensi che il candore delle carni è dovuto al fatto che la donna non lavori ed è qui percepito come un valore estetico positivo: in un breve tratto Verga sembra farci passare la linea ideologica della classe egemone. La baronessa è bella, perché non lavora. Quest’ipotesi, però, andrebbe ricondotta all’interno di più complessi studi sull’estetica, che spiegano meglio i modelli femminili in fatto di colorito della pelle tra Ottocento e Novecento: di certo non si può ridurre il candore delle carni della baronessa solo all’egemonia di una classe, ma ve la si può perlomeno connettere. La sua bellezza, descritta solo attraverso questo dettaglio, è connessa al tenore di vita, mentre la sua posizione narrativa, unita alla prole nel disperato tentativo di salvarsi dalla ferocia popolana, la fa divenire una sorta di angelo del focolare immolato: il bello e buono che si fa vittima. Ancora più nitido il ritratto della plebe schiava di naturali istinti, su cui però non si può ravvisare una vera e propria forzatura. Verga, del resto, è il Fuerbach della letteratura italiana- ci si conceda questa espressione!-, uno scrittore che ha dato molto più di tanti illustri precedenti (ad esempio Manzoni) un senso realista alla narrazione, a discapito del dominio dell’ideologia e non è certo un mistero che i poveri invidiassero i ricchi e ne desiderassero le proprietà, laddove anche la donna era estensione del possesso dei beni. «Rimette in piedi ciò che prima era capovolto, costruisce dal basso, racconta i suoi personaggi nella necessità degli istinti di natura. Dalle sue pagine si configura una filosofia del corpo, la relazione tra l’uomo e l’animale, lo scandalo della catena alimentare, la violenza della storia» (Sergio Campailla: Gli occhi di Malpelo in Giovanni Verga, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo e Tutte le novelle, 2011 Roma, Newton Compton): così ha osservato bene Campailla con una considerazione che fa al caso nostro. Ora, però, soppesando i due opposti, la famiglia nobile e la folla, si noti che la stessa sincera arte del vero che si cuce addosso ai rivoltosi manca nel descrivere la controparte. E già questo desta del sospetto.
Dalle sue pagine si configura una filosofia del corpo, la relazione tra l’uomo e l’animale, lo scandalo della catena alimentare, la violenza della storia» (Sergio Campailla: Gli occhi di Malpelo in Giovanni Verga, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo e Tutte le novelle, 2011 Roma, Newton Compton): così ha osservato bene Campailla con una considerazione che fa al caso nostro. Ora, però, soppesando i due opposti, la famiglia nobile e la folla, si noti che la stessa sincera arte del vero che si cuce addosso ai rivoltosi manca nel descrivere la controparte. E già questo desta del sospetto.
Il figlio sedicenne, «ancora colle carni bianche anch’esso», tenta di fermare gli assalitori in un quadro volutamente parossistico: «puntellava l’uscio colle sue mani tremanti, gridando:- Mamà! Mamà!- Al primo urto gli rovesciarono l’uscio addosso». Ad un tratto, non «gridava più»: si noti l’imperfetto per rendere la continuità con cui il giovane urlava prima di smettere. La baronessa si rifugia nel balcone chiudendo la bocca all’infante che ha con sé, perché non gridi, nell’inutile tentativo di salvarsi, in un atteggiamento suggellato rapidamente con il sostantivo «pazza». La brevitas lapidaria di Verga, ancora una volta, rende tutte le coordinate e il sistema d’ancoraggio della sua narrazione a un complesso ideologico più o meno definito, ma chiaramente identificabile con il punto di vista delle classi abbienti. Lo strazio continua. L’altro figlio della baronessa tenta un’altrettanta vana difesa della madre, ma li «separarono in un attimo». Quando la folla raggiunge la donna, l’afferra con ferocia, «per i capelli», «per i fianchi», «per le vesti», facendola cadere dal balcone: anche qui sembra chiara la metafora sessuale che scorre sottopelle alla narrazione. A questo punto emerge dalla massa la figura del carbonaio che, in mezzo rigo di individualità, strappa il bambino dalle braccia della nobildonna; l’«altro fratello» subisce la fine del figlio del notaio e «gli macinavano le ossa a colpi di tacchi ferrati». Dopo tutta questa frenesia, un’immagine statica: lui morde una mano che lo stringe alla gola e le scuri, pur di non colpirla, «luccicavano in aria», ferme. Se il figlio del notaio è stato un punto di svolta verso una ferocia maggiore, seppure con un barlume d’umanità, qua l’onda rabbiosa è giunta in una fase calante, si estingue in questo quadro statico. Al taglialegna pietoso è succeduto il carbonaio capace di un atto crudelissimo. Si avvia alla conclusione la prima fase della novella.
A questo punto va fatta una riflessione sulla rappresentazione dell’upper class verghiana. Innanzitutto per la benevolenza che spetta in questo caso ai Nelson, generata da una serie di circostanze, vuoi perché contrapposti al pericolo della rivoluzione sociale, vuoi perché di stirpe inglese. L’aridità tipica della decadenza aristocratica di Una peccatrice o di Eva, ma anche quella dei romanzi maturi, su tutti Mastro-don Gesualdo, sembrano appartenere ad autore diverso da quello de Libertà (per una panoramica leggere l’articolo di S. B. Chandler, The Characterization of Upper Class Life in Some of Verga’s Novels, in Italica, vol. 61, No. 2, Summer, 1984, pp. 108-118). Gli aristocratici mettevano in luce i loro paradossi e, in essi, anche squarci di bestialità imbellettata: si veda, ad esempio, il commento al duello tra il pittore Enrico Lanti e il nobile conte Silvani, i quali si «scannavano da perfetti gentiluomini». Certo, si potrebbe dire che non ci sono spazi per poter aprire una critica all’aristocrazia, non c’è modo, in questo contesto di regalare anche solo un dettaglio per ricordarci le radici marce e malate della nobiltà che abitava altre opere verghiane. Ma è un’obiezione debole: se c’è l’agibilità per poter dare con quel “pazza” un momento di pietà e conforto, di comprensione e raggelante disperazione, ci sarebbe stato tutto lo spazio per raccontare, anche incidentalmente, di una qualche negatività. E un esempio, in tal senso, è il modo in cui con poche frasi c’era stato fatto capire quanto il malcostume e il lusso ostentato di altre donne di rango avessero provocato l’odio popolare attraverso il dettaglio dei gioielli («Quanti orecchini su delle facce insanguinate! e quanti anelli d’oro nelle mani che cercavano di parare i colpi!»). I Nelson vengono dunque risparmiati per via della loro provenienza? Dell’aristocrazia non meridionale o siciliana Verga aveva avuto modo di trattare nei suoi primi romanzi. In quel periodo, lo scrittore dimostra un’ambivalente atteggiamento: da una parte la condanna- come già detto- la classe egemone (parliamo principalmente di aristocratici, in un’Italia in cui la borghesia emergeva lentamente rispetto che nel resto d’Europa), dall’altra manifesta il desiderio di cooptazione nell’elite sociale. Di fronte all’immobilismo del mondo antico da cui proviene, il «motore dell’aspirante scrittore è, con una parola oggi impronunciabile, la gloria, più concretamente il successo: nei beni materiali e naturalmente con le donne. Le prime opere verghiane appaiono in questo senso imbarazzanti per trasparenza autobiografica» (Campailla: cit., p. 8). Riguardo alla contessa di Prato, Narcisa Valderi, che si innamora di Pietro Brusio, letterato in ascesa, in Una peccatrice, Campailla fa notare che, non solo l’autore non ha mai visto allora alcuna contessa di Prato, ma che quello «che importa è che la donna è settentrionale, e anche contessa» (Ibidem). C’è, insomma, una pressione verso l’immaginazione di un nord avamposto di civiltà o riscatto sociale; ma questo non motiva una particolare indulgenza nei confronti dei nobili settentrionali. E se il Verga di Libertà è quello che «ormai ritornava alla materia dei romanzi giovanili, ma vi ritornava con una personalità mutata, come uno che ha compiuto un intero giro di pista» (Campailla: cit., p. 13), di certo non era cambiata la sua opinione del ceto decadente, oramai fermamente accostato alla borghesia rampante nell’essere oggetto dell’attenzione critica dell’autore. Verga ci raccontava la “fiumana del progresso” e le vittime-carnefici della sua tragica avanzata, si fossero chiamati Mazzarò o Leyra. Ma questo è ben noto. Ci rimane, alla fine di questo ragionamento, se la logica non ci inganna, un pugno di mosche: i Nelson sono tutelati, forse in quanto vittime: questo possiamo credere, sforzandoci non poco.
Tornando al testo, l’ultimo capoverso di quella che è generalmente indicata come la prima parte del racconto comincia con un riferimento a «quel carnevale di luglio» che è stata la rivolta. C’è ovviamente un nesso chiaro allo spirito carnascialesco dei ruoli invertiti e del capovolgimento dell’ordine sociale dei Saturnali antichi, qui fotografato al di fuori della sua decorrenza naturale e, quindi, doppiamente assurdo, perché fuori dal suo periodo nel tempo lineare e in quello ciclico, cioè fuori dal periodo storico che lo accoglieva e dal periodo dell’anno preposto ad esso. Il paese è oramai privo di religione e dissacrato: «continuava a suonare a stormo la campana di Dio, fino a sera, senza mezzogiorno, senza avemaria, come in paese di turchi». Il messaggio è chiaro: chi contesta il trono, contesta anche l’altare, quindi non è in grazia di Dio. Fuori, intanto, un’immagine omerica dell’abbandono dei cadaveri: «non si udivano altro che i cani, frugando per i canti, con un rosicchiare secco di ossa nel chiaro di luna che lavava ogni cosa». Con un solo capoverso, Verga mette in chiaro la sconsacrazione del paese, l’indissolubile legame tra la religione e il potere, mentre recupera astutamente le radici dell’Occidente e l’antico incubo della decomposizione e della mancata cura del corpo di chi è morto.
La sequenza successiva riprende il tema dell’animale come simbolo dell’esclusione dal genere umano: «Senza messa non potevano starci, un giorno di domenica, come i cani!». Il popolo non si sa autorganizzare e soffre la mancanza di ordini. Viene ripreso il fazzoletto, quello che avevamo trovato ad inizio della storia: adesso «penzolava sempre […], floscio, nella caldura gialla di luglio». È inerme, placido. E non ricomparirà più- troveremo un fazzoletto bianco con cui gli avvocati del processo finale si asciugheranno la bava alla bocca-. Per cui è d’obbligo fare una riflessione su questo elemento, all’apparenza secondario. Nel 1920 uscirà un’edizione di Novelle rusticane, in cui questo fazzoletto sarà diventato rosso (Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese: La scrittura e l’interpretazione, 2001 Palumbo, p. 236). Sono note le antipatie di Verga per i socialisti, ma ci deve allarmare il fatto che utilizzi il vessillo, la bandiera, caricata di un simbolismo non indifferente per mistificare i fatti o la loro lettura. Viene dunque da chiedersi se abbia usato a caso un fazzoletto, in luogo di un supporto più “istituzionale”.
La scena della spartizione delle proprietà ricava un senso di bestialità dal contrattare senza ordine dei convenuti. La sequela di battute contrastanti e anche la facilità dell’accusa vanno ad alludere e a preludere ad una quasi imminente trasformazione dei berretti in cappelli. «Quel Nino Bestia e quel Ramurazzo avrebbero preteso di continuare le prepotenze dei cappelli!» e «Ladro tu e ladro io» oppure «chi voleva mangiare per due avrebbe avuto la sua festa come quella dei galantuomini!». Si direbbe che si stia per scatenare una situazione simile a quella dell’orwelliano La fattoria degli animali, dove i maiali che hanno cacciato i padroni imparano a camminare su due zampe. A chiudere il quadro, il taglialegna, figura farsesca: «brandiva in aria la mano quasi ci avesse ancora la scure».
L’annuncio dell’arrivo del generale «che veniva a far giustizia» ci offre uno spunto interessante. Mentre il suo contingente sale «lentamente per il burrone», gli abitanti non fanno nulla. L’immobilismo è così tradotto: «sarebbe bastato rotolare dall’alto delle pietre per schiacciarli tutti. Ma nessuno si mosse». Gli uomini «con le barbe lunghe» si lasciano prendere dai garibaldini: dai «giovanetti stanchi, curvi sotto il fucile arrugginito» e da «quel generale piccino sopra il suo gran cavallo nero, innanzi a tutti, solo». È un immobilismo disarmante, giustificato dalla grande fortezza d’animo degli aggressori: come se questi fossero in minoranza rispetto ai rivoltosi. Questa stessa incapacità di reagire ce l’hanno anche i paesani che gridano contro Bixio nel racconto di Cesare Abba, reduce garibaldino: «Dopo Bronte, Randazzo, Castiglione, Regalbuto, Centorbi, ed altri villaggi lo videro, sentirono la stretta della sua mano possente, gli gridarono dietro: Belva! ma niuno osò muoversi» (Cesare Abba: Da Quarto a Volturno, 1965 Bologna, Zanichelli, p. 206). Ora, posto che l’intervento nella realtà dei fatti fu invocato dal console inglese per via della morte di un contabile di un latifondo inglese, forse anche con l’intento di normalizzare le frange di sinistra del movimento garibaldino, la rappresentazione del contingente risulta essere una specie di contrappeso eccessivo, un prodotto retorico che rivela forse le tracce di un certo senso di colpa. E alle stesse coordinate retoriche si rifanno entrambi gli scrittori, calcando la mano sulla grandezza di Bixio, sul suo carattere focoso, sulla giovinezza candida dei garibaldini. Prendiamo un estratto dall’opera di Abba (Cesare Abba: Da Quarto a Volturno, 1965 Bologna, Zanichelli, pp. 206-207).
«Bixio in pochi giorni ha lasciato mezzo il suo cuore a brani, su per i villaggi dell’Etna scoppiati a tumulti scellerati. Fu qua e là, apparizione terribile. A Bronte, divisione di beni, incendi, vendette, orgie da oscurare il sole, e per giunta viva a Garibaldi. Bixio piglia con sé un battaglione, due; a cavallo, in carrozza, su carri, arrivi chi arriverà lassù, ma via. Camminando era un incontro continuo di gente scampata alle stragi. Supplicavano, tendevano le mani a lui, agli ufficiali, qualcuno gridando: Oh non andate, ammazzeranno anche voi! Ma Bixio avanti per due giorni, coprendo la via de’ suoi che non se ne potevano più, arriva con pochi: bastano alla vista di cose da cavarsi gli occhi per l’orrore! Case incendiate coi padroni dentro; gente sgozzata per le vie; nei seminari i giovanetti trucidati a pie’ del vecchio Rettore; uno dell’orda è là che lacera coi denti il seno di una fanciulla uccisa. «Caricateli alla baionetta!». Quei feroci sono presi, legati tanti che bisogna faticare per ridursi a scegliere i più tristi, un centinaio. Poi un proclama di Bixio è lanciato come lingua di fuoco: «Bronte colpevole di lesa umanità è dichiarato in istato d’assedio: consegna delle armi o morte: disciolti Municipio, Guardia Nazionale, tutto: imposta una tassa di guerra per ogni ora sin che l’ordine sia ristabilito». E i rei sono giudicati da un Consiglio di Guerra. Sei vanno a morte, fucilati nel dorso con l’avvocato Lombardi, un vecchio di sessant’anni, capo della tregenda infame. Fra gli esecutori della sentenza v’erano dei giovani dolci e gentili, medici, artisti in camicia rossa. Che dolore! Bixio assisteva con gli occhi pieni di lagrime»
Tornando al testo verghiano, il generale mette a dormire i suoi volontari «come un padre», dopo essersi fatto portare della paglia in una chiesa. È l’apoteosi del paternalismo: Bixio si consacra prima della battaglia e prende simbolicamente il posto provvisorio di coloro che regolavano la vita sociale partendo proprio dal luogo di culto, dove dorme umilmente su un povero giaciglio. L’accettazione fatalista sottesa all’immobilismo dei rivoltosi si può accostare solo ad altri personaggi verghiani, irrimediabilmente vinti. Ma a questa loro condizione non si accosta quasi alcuna vicinanza, ma anzi si continua nel ritratto di Bixio generale intemperante, pronto ad entrare in chiesa per svegliare i suoi «sacramentando come un turco». Difficile trovare un’espressione meno mistificatrice di «Questo era l’uomo»: come a dire che era così per natura e non ci si poteva far niente. La successiva fucilazione del “nano”, di cui abbiamo già parlato, assieme a «cinque o sei, […] i primi che capitarono» è il sigillo dell’incolpevolezza del comandante: il suo è un gesto involontario e dettato dall’impeto, come un delitto privo di premeditazione. Ora che l’ordine è chiaro, ci si può lasciare sfuggire qualche briciolo di umanità anche per il taglialegna, che piange «come un ragazzo» prima di morire, per le parole e l’urlo della madre. Segue un’immagine infantile: i rumori degli spari del plotone d’esecuzione somigliano ai «mortaletti della festa». L’idea che passa è quella di un accostamento tra condannati e adolescenza, tra popolo e incoscienza.
A questo punto il tempo della storia si allunga, quello del discorso si abbrevia: Verga sceglie di trattare tutto il discioglimento in maniera sommaria. Compaiono i «galantuomini» (senza corsivo), i «giudici per davvero». Sono personaggi da subito caricaturizzati: stremati dal viaggio a dorso di mula, continuano ad accusare dolori anche durante gli interrogatori. Le donne vengono ritratte nella loro sofferenza, durante il trasporto dei prigionieri: «li seguivano correndo, […] zoppicando, chiamandoli a nome ogni volta». Si noti come la frase «Alla città li chiusero nel gran carcere alto e vasto» enfatizzi l’ambientazione urbana del dramma. Progressivamente il testo ci restituisce Verga come lo conosciamo: «i poveretti divenivano sempre più gialli in quell’ombra perenne». Il motivo della miseria emerge in tutta la sua concretezza, partendo proprio dalla condizione delle donne: il «letto nello stallozzo costava due soldi; il pane bianco si mangiava in un boccone e non riempiva lo stomaco». Ritornano a casa, in ordine non casuale, «prima le mogli, poi le mamme». Poi un copione già visto altrove in Verga: «un bel pezzo di giovinetta si perdette nella città e non se ne seppe più nulla». La città è un luogo di perdizione e gli amori sono fatti a pezzi dal bisogno.
Subito dopo, berretti e cappelli convengono sul fatto che ognuno ha bisogno dell’altro e, quindi, scrive Verga, «Fecero la pace». Un po’ sbrigativo, forse, quanto a credibilità narrativa, anche perché una complessa trama di conflitti individuali e di categoria dovrebbe lasciare un qualche strascico o, perlomeno, favorire l’esilio di un qualche ‘Ntoni. Vero è che la folla è la protagonista della rivolta e non c’è stato modo di individuare un qualche eroe, pur negativo che fosse. Ma, anche nel quadro del bozzetto e dell’allusione, Verga non ci dice nulla. Ci aspetteremmo un figlio- dell’una o dell’altra parte- che giuri vendetta e si consumi nell’odio, qualche berretto che tragga la morale arricchendosi spietatamente e poi lamentandosi della sua mortalità, il disfacimento dei beni dei notabili, magari al tavolo da gioco. Invece, niente. L’orfano dello speziale è contento di rubare la moglie a Neli Pirru, che gli aveva ammazzato il padre; questa ha delle «ubbie», dei pregiudizi infondati, che il marito si vendichi, ma viene rassicurata dal concubino che il coniuge legittimo non uscirà mai di galera. Tralasciando la posizione della donna come possesso, viene da chiedersi che fine abbia fatto la grazia di Dio e il giudizio dell’autore in materia- forse da leggere tra le righe nella giustificazione del darwinismo sociale o nella silenziosa condanna della volubilità femminile?-. Damnatio memoriae volontaria da parte di quasi tutto il paese: «Ormai nessuno ci pensava; solamente qualche madre, qualche vecchierello […], al vedere gli altri che parlavano tranquillamente dei loro affari coi galantuomini, dinanzi al casino di conversazione, col berretto in mano, e si persuadevano che all’aria ci vanno i cenci»: vince il fatalismo, come ci aspetteremmo.
Il processo di tre anni riduce gli imputati a «morti della sepoltura». Tutti accorrono a vedere, «come a una festa». Gli uomini in gabbia sono ancora una volta raffigurati come animali: essi sono «stipati nella capponaia- ché capponi davvero si diventava là dentro!». Questa volta non è tutta la comunità ad essere subumana, animale, come lo era stata fino a prima dell’arrivo di Bixio, ma una sua porzione, quella estirpata e messa sotto accusa: da certo punto di vista, la pubblica mostra dei “capponi” richiama alla mente un processo di catarsi collettiva, dove i sopravvissuti guardano agli uomini-animali sacrificali e lasciano che essi espiino le colpe di tutta Bronte. Di qui si passa in rapida rassegna la ritualità artificiosa della legge moderna, esposta anche ad un certo sarcasmo: gli «avvocati armeggiavano, fra le chiacchiere, coi larghi maniconi pendenti, e si scalmanavano, facevano la schiuma alla bocca, asciugandosela subito col fazzoletto bianco, tirandoci su una presa di tabacco». Il rito pagano e antico della purificazione collettiva si contrappone a quello artificiale delle norme.
Di fronte ai giudici, dodici galantuomini sonnecchiano- forse i rappresentanti dell’accusa- ed esprimono una sorta di solidarietà di classe per i loro pari caduti sotto i colpi dei rivoltosi: «si dicevano che l’avevano scampata bella a non essere galantuomini (nota la mancanza di corsivo) di quel paesetto lassù». Gli accusati sono definiti prima «poveretti» e poi «pallidi». A seguire, abbiamo solo l’incipit della formula di rito della condanna, emessa dai giudici per bocca del «loro capo», «quasi pallido al pari degli accusati»: Verga preferisce l’ellissi, che è anche un modo per svincolare dalla concretezza della pena e per mettere tutti gli accusati sullo stesso piano. Al che, mentre viene portato via, il carbonaio- figura sicuramente non scelta a caso- pronuncia le celebri frasi: «O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra! Se avevano detto che c’era la libertà!…». Vengono richiamati il motivo dell’avidità personale, il fraintendimento del messaggio risorgimentale da parte del popolano, ma si lancia anche, se vogliamo, uno strale contro il movimento carbonaro, i primordi bombaroli del Risorgimento- a meno che non si voglia credere che questa figura sia stata scelta fortuitamente da Giovanni Verga.
In seconda istanza, partendo dalle parole del carbonaio, c’è un ragionamento da fare sul vocabolo “libertà”. In generale, in Verga si mette in atto l’affermazione dell’impossibilità del simbolismo nella società moderna: esso può esistere solo in quella arcaico-rurale, dove la corrispondenza tra particolare e universale ha un significato forte, immerso nei valori della natura e della solidarietà (vedi l’interpretazione del finale dei Malavoglia in Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese: La scrittura e l’interpretazione, 2001 Palumbo, p. 282). Da questo punto possiamo muovere verso la scoperta dello svuotamento di significato della parola “libertà”, che nella prospettiva di rivolta sociale non significa più nulla, anche perché proiettata al di fuori del mondo arcaico (Luperini: Conclusione sui temi del convegno «Famiglia e società nell’opera di Giovanni Verga»: a proposito della religione della famiglia, in AA.VV., Famiglia e società nell’opera di Giovanni Verga, a cura di N. Cacciaglia, A. Neiger, R. Pavese, Olschki, Firenze 1991) e dal mito risorgimentale, quasi queste due figure coincidessero o il secondo segnasse la fine della prima. Anzi, da questo svuotamento dei simboli, che è proprio dell’era moderna, possiamo cogliere uno spiraglio di vertigine nichilista, uno smarrimento di valori che fa capolino e che si potrebbe trovare al di sotto del conservatorismo verghiano. Prima del Risorgimento, quindi, prima che la “fiumana” esploda, l’ordine cognitivo, la sintassi emozionale sono ben ordinati; dopo, sembra esserci solo sfaldamento.
Posto che “Libertà” è l’unico caso in cui la rivolta in Verga viene descritta in maniera drammatica e con violento espressionismo, non con carica comica o grottesca-caricaturale (Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, La scrittura e l’interpretazione, 2001 Palumbo, p. 236), dovremmo chiederci se quest’insieme di coincidenze, da noi analizzate nell’ambito dell’intera novella, siano un caso o siano l’espressione di tutto un grande abisso che sottende alla scrittura dell’ultimo Verga. A tal proposito sarebbe interessante comprendere l’intelaiatura dei rapporti tra i personaggi, con l’ambiente e quella tra le opere e l’immaginario collettivo, al fine di accertare l’affermazione disarmante dei valori della società industriale e la conseguente formazione di una narrativa “della crisi”, individuando le basi da cui muoverà l’opera pirandelliana e, in generale, tutta la letteratura della civiltà industriale in Italia.
di Giulio Pitroso
 ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.
ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.