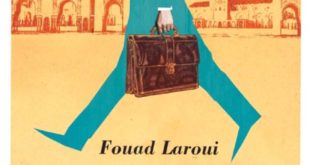A inizio giugno del 1860, il 2, Garibaldi promulgò un decreto per la redistribuzione della terra. La catena di insurrezioni popolari che ne seguì portò a una delle pagine più tristi e controverse della storia italiana: nell’agosto di quell’anno l’unificazione si macchiava di una sorta di peccato originale, forse uno dei tanti, procedendo poi all’insabbiamento ideologico dei propri crimini.
S’innescarono rivolte contro l’upper class siciliana e i luogotenenti del potere borbonico. I disordini dovrebbero rientrare nel solco della rivoluzione o presunta tale che Garibaldi sta operando con lo sbarco di Mille, se non fosse che proprio i garibaldini provvedono a sedarli. Sulla base della citata promessa di redistribuzione delle terre, la popolazione di Bronte, analogamente a quanto fecero altri paesi siciliani- si pensi alla rivolta di Arcara Li Fusi raccontata da Vincenzo Consolo in Il sorriso dell’ignoto marinaio-, si ribellò prima dell’arrivo dei garibaldini alle autorità costituite, ai nobili locali, i Nelson, discendenti del famoso ammiraglio, e i loro luogotenenti locali. Garibaldi inviò Bixio, che procedette a una durissima repressione.
Libertà, prima pubblicata in “Domenica letteraria”, poi raccolta nel 1883 in Novelle rusticane, di Giovanni Verga è uno dei racconti più noti sul Risorgimento. Fu scritto nel 1882, ventidue anni dopo i fatti di Bronte. La sua fama è stata costruita principalmente dall’essere una novella su uno dei lati oscuri del processo di unificazione, narrata attraverso gli occhi dell’ideologia risorgimentale. Meglio, secondo una nota analisi di Sciascia, Verga e la libertà, attraverso una vera e propria mistificazione dei fatti, scoperta soprattutto grazie al lavoro di Benedetto Radice. E’ interessante ritornare su questo pezzo di letteratura siciliana per capire quanto abbia agito l’elemento ideologico nella rappresentazione di un evento storico, dell’equilibrio sociale, per comprendere le incoerenze di fondo dell’Italia che si fece e degli Italiani che non si fecero mai. Insomma, più che per fare una disamina storica, per farne una lettura critica, quasi semiologica.
Anche perché la lettura storica e critica esiste già e non l’ha fatta solo Sciascia; ed esiste anche una nota trasposizione cinematografica cui collaborò. Certo la sua è la più nota, non solo per la caratura dell’autore, ma per gli elementi sconcertanti che ne vengono fuori: la storia raccontata da Verga ha totalmente eliminato il sindaco borghese, l’avvocato Lombardo, leader dei comunisti (sostenitore dei diritti del Comune contro quelli del Duca), condannato ingiustamente quale responsabile del massacro, e ha fatto diventare nano- condannato anche questo- quello che alle cronache risultava essere una specie di scemo del villaggio, Nunzio Ciraldo Fraiunco, la cui unica colpa era stata di aver profetizzato, vagando per il paese prima dei disordini, un futuro disgraziato per i notabili. Oppure la mistificazione del personaggio Bixio quale uomo intemperante, che, proprio per le inclinazioni caratteriali, faceva fucilare quasi a casaccio un gruppo di rivoltosi: un modo per cancellare l’imbarazzante processo sommario che precedette la condanna a morte, poco prima della quale il povero pazzo del paese continuava a ripetere, baciando uno scapolare, che la Madonna lo avrebbe salvato.
A noi interessano, in questo luogo, più i simboli e la rappresentazione delle idee e delle azioni, il retroterra lessicale, la forza delle cosiddette idee performanti sull’immaginario collettivo e la sua rappresentazione. Ci interessa, è vero, anche la tecnica di Verga, che hanno analizzato fior fiore di studiosi (si pensi a Luperini), meglio e prima di noi: facendo tesoro della modesta parte di questo patrimonio che conosciamo e di tutti quegli strumenti di lettura critica e semiologica utili, cercheremo di scarnificare il mito e la sovrastruttura della novella verghiana La libertà.
«Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo, e cominciarono a gridare in piazza:- Viva la libertà!-». La narrazione comincia in medias res. Al centro vi è subito la folla, identificata subito con un elemento non umano, «come il mare in tempesta» che «spumeggiava e ondeggiava». Segue un’interessante fotografia del massacro dei notabili, o meglio della voce della folla che dà addosso a questo o a quello, in una sorta di catalogo delle autorità che subiscono l’ira popolare: il barone ed i suoi campieri, il prete «del diavolo», il ricco «epulone», lo sbirro, il guardiaboschi. Un quadro del potere rurale e delle sue articolazioni, una sorta di succursale tipicizzata del grande sistema di potere fondato sull’alleanza trono-altare. Il solito sfondo dicotomico birritti-cappeddi, berretti-cappelli, della società siciliana, dominata dai secondi, i cosiddetti «galantuomini» qui viene assunto nelle sue sfaccettature. Si noti che Verga usa il corsivo nella parte di testo cui facciamo riferimento, salvo poi non usarlo durante il processo riferendosi ai giudici: in merito potremo formulare un’ipotesi in avanti sui termini “cappelli” e “galantuomini”. Tra i rivoltosi spicca una «strega», che è armata «solo delle unghie»: da qui la facile lettura della caratterizzazione negativa operata da Verga. L’incipit è violento, immediato, concitato: non a caso, è ovvio. Proiettare il lettore immediatamente nella confusione, nella crisi, nel panico è anche un modo per coinvolgerlo più con la preda che con l’assalitore; oppure è un focus diretto sul popolo, da cui poi staccarsi gradatamente, riconoscendo tra poche decine di righe lo status inumano della folla, quando il massacro si farà più violento e ingiustificato. Peggio ancora, per la seconda ipotesi, nella mattanza si farà sempre più chiara e nitida l’identità delle vittime e sempre più torbida e compromessa quella dei carnefici: assieme al distanziamento dai ribelli, non si potrà che accompagnare il lettore lontano dalla carica simbolica della parola “libertà”, citata da subito come elemento-chiave della storia. In questo processo di degradazione, di svuotamento di significato, la libertà come valore e il popolo come entità diventeranno contenitori sterili, vessilli male interpretati di pochi. Ma su questo ritorneremo dopo, quando il sopracitato processo sarà giunto a termine: il popolo rabbioso sarà ridotto a pochi facinorosi e i valori all’infuori dell’apparato ideologico risorgimentali diverranno inutili e nocivi.
La scena seguente è dominata da don Antonio, un prete corrotto braccato dai rivoltosi, che predicava «l’inferno per chi rubava il pane», preso dal terrore di morire in «peccato mortale», laddove esso non è altro che il rapporto con la gnà Lucia, «che il padre gli aveva venduta a 14 anni, l’inverno della fame, e riempiva la Ruota e le strade di monelli affamati». Il prete, così raffigurato, tradisce forse un pregiudizio anticlericale alla base della narrazione, se non vuole addirittura, rendendo realistico il tutto, attribuire alla decadenza dei costumi tra i notabili parti delle colpe della situazione contro cui si ribella il popolo. Tra questi spicca un altro personaggio negativo, che fa il paio con la strega di prima, è il «monello sciancato» che raccatta il cappello del reverendo e vi sputa dentro. Ci si potrebbe leggere un legame tra i monelli affamati e quello ora nominato, quasi una sorta di nemesi. Prendendo in considerazione il fatto che anche lo stesso don Antonio è responsabile dell’esistenza di tanti monelli, quelli procreati dalla gnà Lucia, si avvalorerebbe la tesi per cui Verga, in questo segmento narrativo, voglia puntare il dito contro la classe dirigente corrotta; ma sarebbe meglio dire che lo punti contro il clero decadente, secondo un tema caro a buona parte dell’ideologia risorgimentale. Del resto, condannare la lontananza di un pezzo della classe dirigente dalla rigidità nei comportamenti e nella morale disinnesca qualsiasi spiraglio ad una critica al sistema in sé: suggerisce, invece, un vero viatico di salvezza nella forza della tradizioni. Si potrebbe anche dire che in questa fase è in atto il meccanismo di straniamento e che è il popolo a pensare che il prete sia deprecabile, ma, visto che esso, secondo quanto diremo tra poco si esonera dallo stare all’interno dell’umanità- e quindi da una facoltà di giudizio in conformità con il senso comune- e che il meccanismo narrativo in questione sarebbe poco marcato, escluderei questa ipotesi. Quanto alla critica alle classi dirigenti, noteremo, invece, come il narratore ci risparmi uno dei suoi cavalli di battaglia, l’inadeguatezza dei nobili al nuovo corso sociale ed economico, vissuto quasi come una colpa: i Nelson sono ritratti come degli agnelli sacrificali, senza accenni palesi a eventuali loro debolezze o incapacità.
Una volta morto, il prete diventa «carne di cane», con la quale i monelli si sarebbero potuti saziare, se fosse valsa a qualcosa. Questo è un elemento interessante: aldilà dell’immagine cruda, da giustizia biblica, Verga identifica il male, il cattivo, il peggiore con un animale, in questo caso il cane. Un procedimento di identificazione del diverso nell’animale, a prescindere dalle sue azioni, è quello dell’asino di Rosso Malpelo, ad esempio: le basi su cui scaricare tutto il malessere della società sono costituite dagli animali o dagli uomini che vi assomigliano, prendendone le sembianze quando si mettono contro l’ordine costituito e i suoi valori, o meglio ancora contro delle norme che sono al di fuori del tempo, come nel caso della non meno celebre Lupa o ne La caccia al lupo in “Novelle sparse”. Don Antonio paga la sua degradazione trasformandosi nell’animale, staccandosi totalmente dalla propria comunità e, immediatamente, dall’umanità. Come se al di fuori della prima, non esistesse la seconda.
Se il prete è diventato un cane, allora la folla è un lupo, una specie di cane che si difende e offende. Per spiegare questa diversità occorrerebbe un’articolata esposizione sulla natura e le forme del bestiario verghiano. Basti riprendere dal testo: «il lupo, allorché capiti affamato in una mandara, non pensa a riempirsi il ventre e sgozza dalla rabbia». La folla, d’ora in avanti, è senza ragioni legittime, perché avrebbe potuto placare la propria fame con quello che aveva avuto: il che la dovrebbe scagionare dall’avere una volontà cosciente alla base di tanto spargimento di sangue. Ma non è questo il senso della cosa: la folla è già al di fuori dell’umanità, già giudicata a priori, non servono attenuanti; i dettagli crudi avvaloreranno questa tesi e scaveranno un solco tra i rivoltosi e il Risorgimento, descritto dalla retorica contemporanea e successiva a Verga come un glorioso viatico di imprese più o meno dolorose.
Don Paolo, che ritorna dalla vigna, colpita da un non meglio identificato male, è un padre di famiglia sventrato davanti ai figli e alla moglie, ritornato dalla campagna con un somarello con le bisacce «magre in groppa». Un quadro ancora più straziante è la morte del figlio del notaio, Neddu, immediatamente caratterizzato come un «un ragazzo di undici anni, biondo come l’oro». E’ qui evidente quanto si voglia rendere depositari di qualità positive i notabili: nel caso di don Paolo quelle del focolare domestico, sottese alla sua immagine di sciagurato viticoltore; nel caso del figlio del notaio, la bellezza e l’innocenza. La violenza travolge queste virtù con crudezza agghiacciante: Neddu non vuole morire come il padre e chiede grazia colle mani. La pietà della folla è il colpo del taglialegna, «quasi avesse dovuto abbattere un rovere di cinquant’anni»: l’uomo trema come una foglia, dettaglio non irrelevante. A questo momento di “debolezza” segue la giustificazione facile di «un altro»: «Bah! egli sarebbe stato notaio anche lui». In poche righe Verga ci ha restituito un ritratto della folla che conosce solo il linguaggio della violenza: attraverso l’atto violento si esprime anche nella pietà e, quando affiora la voce dei suoi strumenti umani, è una voce gridata e livida di rancore, che mette a tacere l’emergere compassionevole dell’individuo. Tutto questo è rimarcato al capoverso successivo da un «Non importa!» iniziale.
«Non era più la fame, le soperchierie, che facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente». La violenza diventa femminile, «le donne più feroci ancora», è «l’ira in falsetto», che attacca chi veniva in chiesa «colla veste di seta» e dilaga persino dentro le alcove. Il cosiddetto sesso debole diventa bestiale. La donna integra, invece, quella che mantiene e preserva uno status da tutrice del focolare- e con esso la propria femminilità- è la baronessa, che vedremo al centro di un momento commovente. Per ora, ha fatto barricare il portone e si avvale del fuoco dei campieri per tenere lontana la folla. Da qui sembra delinearsi una sorta di quadro di manzoniana memoria, per cui l’interiorità, nello specifico, il complesso di cose che costituisce quella femminile, è appannaggio solo di chi sa restare umano, di chi si può permettere di esserlo sempre e comunque e non degli umili: e questo desta un campanello d’allarme, non è molto verghiano ed è forse solo un’impressione. L’insieme di battute che seguono forse si possono assumere come un flusso di coscienza urlato della folla femminile, delle «donne più feroci»; sicuramente come la testimonianza delle ragioni sanguinarie, un misto di invidia- forse anche legittima- e rancore, di questa parte dei rivoltosi: «- Tu che venivi a pregare il buon Dio colla veste di seta! -Tu che avevi a schifo d’inginocchiarti con la povera gente! – Te’! Te’!». Se è però questa l’interiorità della folla-animale, pare che su di essa s’indugi poco o con superficialità: questo perché far parte della massa impedisce l’accesso a una psicologia autentica. Inoltre, rileggendo le battute è evidente, così come nell’assalto contro il prete corrotto, che anche qui la religione è al centro del conflitto, quasi non si fosse assunta il sacro compito di alleviare l’astio e disinnescare l’odio di classe, lasciando che la vanità della «seta» e, quindi, la decadenza dei costumi prevalessero. Del resto ricompare una sorta di giustizia biblica a chiudere il quadro: «Quanti orecchini su delle facce insanguinate! e quanti anelli d’oro nelle mani che cercavano di parare i colpi!».
Questa fuoriuscita dall’umano e consequenziale appiattimento del profilo psicologico delle donne povere avviene, non perché la donna nobile sia esente dall’essere una bestia, ma poiché la bestialità può essere amica della fame; peggio ancora, perché nella fame non si resiste alla tentazione di violare i mos maiorum della narrativa verghiana. Insomma, quando i poveri vengono meno alle leggi non scritte della storia, all’attaccamento al loro luogo e al loro status, escono dal mondo degli uomini, esattamente come potrebbero fare i ricchi e i notabili. Si pensi, ad esempio, a chi non si conforma alla propria natura e pretende di comprare o prendere la nobiltà, come il protagonista di Mastro-don Gesualdo. Oppure a chi vive talmente tanto all’interno della logica materialistica e fuori dalle leggi non scritte, tanto da impazzirne, come il Mazzarò de La roba. E qui però bisognerebbe fare un approfondimento per cui qui non v’è spazio, sul senso tragico che personaggi simili esprimono, anche in contesti corali, e che ne La libertà fa sentire a malapena qualche voce della folla. Questo, forse, perché nella degradazione e nella violazione delle norme non scritte la folla non ha individui, ma anzi fa di tutto per fare a meno della singolarità: finora, a parte una strega, il taglialegna e il monello non abbiamo incontrato persone. Oppure perché essa è divenuta un singolo, non un sistema di personaggi in una narrazione corale, ma non le si vuole dare dignità alcuna. Gli individui sembreranno recuperare se stessi solo dopo la carneficina.
Interessante è notare come il celebre meccanismo dello straniamento di Verga venga meno o si noti poco fino a questo punto: a partire da «Non importa! Ora che si avevano le mani rosse di quel sangue, bisognava versare tutto il resto. Tutti! Tutti i cappelli!». Fino a qui, invece, avevamo avuto un giudizio moralistico, di parte, conforme a quello che l’autore e forse il lettore dell’epoca si potevano attendere essere il senso comune: per esempio, nel passo di Neddu: «Ma il peggio avvenne appena cadde il figliolo del notaio». Ulteriore elemento, nel primo passo si evidenzia il corsivo “cappelli”, che fa il paio con il “galantuomini” di cui discutevamo all’inizio: ci pare che Verga voglia caratterizzare questo termine come figlio del pensiero popolano, al contrario di come farà riferendosi ai giudici e togliendo il corsivo. Il corsivo, quindi, serve a prendere il punto di vista dei rivoltosi, ma attraverso un dispositivo palese, perlomeno evidente al lettore smaliziato. Altro punto: lo straniamento dell’estratto in considerazione viene immediatamente lenito: «Non era più la fame, le soperchierie, che facevano ribollire la collera. Era il sangue innocente». Sembra quasi che Verga abbia messo quest’aggiustamento apposta, magari in una seconda stesura.
I popolani assaltano la dimora della baronessa. La frase «Prima c’era la pena di morte per chi tenesse armi da fuoco», riferita ai rivoltosi armati non alla pari dei campieri, può fare pensare a una sorta di giustificazione nei confronti di una legislatura severa in materia, come anche a una sorta di spiegazione razionale alla conformazione anomala di una rivolta senza armi nel pieno di un processo di matrice rivoluzionaria. Va da sé che i moti risorgimentali erano sempre stati armati anche grazie ad una rete patriottica, che faceva riferimento a soggetti politici e organizzazioni per il reperimento di fondi. Dire che la rivolta è senza armi da fuoco, in un certo senso, equivale anche a dire che è al di fuori del disegno di questa rete e che con questa rete risorgimentale nulla ha a che fare.
(prima parte)
di Giulio Pitroso
 ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.
ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.