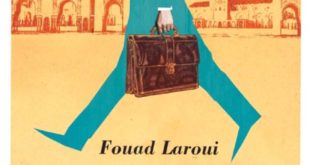«L’ingegnere che stava lì era il più vecchio dell’accademia; aveva la faccia e la barba giallastre, le mani e le vesti pieni di sudiciume. Quando gli venni presentato mi abbracciò con effusione, ma non gli fui punto grato di codesta cortesia. Costui, fino dal primo giorno del suo ingresso nell’accademia, indagava sul modo di ritrasformare gli escrementi umani nel primitivo aspetto dei cibi da cui risultavano, separandone le varie parti e depurandole dal fiele, che è appunto la causa del puzzo che mandano gli escrementi.
Egli faceva svaporare il fiele e toglieva la schiuma derivante dalla saliva» (“I viaggi di Gulliver”, Jonathan Swift, trad. di Aldo Valori)
Quando Gulliver, quello dei famosi viaggi narrati da Swift, visita Lagado e la sua accademia, si mette in scena un divertente catalogo dell’astrattezza e della vacuità di studi e studiosi che hanno perso contatto con la realtà, che addirittura disprezzano le attività pratiche. Un’illustrazione che è sicuramente satira nei confronti della Royal Society contemporanea a Swift, ma che s’adatta benissimo ai nostri tempi, specie alla condizione degli umanisti.
Un rapido zapping alla televisione e uno sguardo ai prodotti dell’industria culturale del nostro tempo, in Italia peggio che altrove, ci dovrebbero far riflettere su tutto il terreno perso dai nostri cervelli. Mentre gli anni Zero ci propinavano l’apoteosi dei media berlusconiani, di Maria De Filippi, di Wilma De Angelis e tutti gli altri dei della fascia pomeridiana, di Studio Aperto, per non parlare del format Grande Fratello, le nostre teste perdevano l’occasione per riscattarsi e prendevano spesso quella linea caratteristica della classe politica, più impegnata a scannare il tempo in battibecchi che distolgano l’attenzione sui nostri problemi reali che ad affrontare i bisogni dei loro elettori. I famosi “problemi reali del Paese” che abbondano sulla bocca degli uomini del Partito Democratico più che altrove, articolati e nascosti nella dialettica e nel lessico veltroniano, sono rimasti, però, insoluti, incattiviti, a volte inesprimibili: tra televisione e audience, tra elettori e personale politico si consuma e si è consumata una distanza disastrosa. Fatta eccezione per qualche oasi salvifica, l’Umanesimo è vastamente bandito, come anche, insieme ad esso qualsiasi strumento di riflessione dai toni genuinamente ribelli: per capirci, Carlo Freccero alla testa di Rai 4- ancora per poco– e Magazzini Einstein non possono risarcirci di scene come quella di Barbara D’Urso che imbocca la figlia di Carmen Russo.
Il problema è importante: si è usato tanto di quell’inchiostro nel descrivere il ruolo e, addirittura, l’utilità della letteratura e dell’Umanesimo nel Novecento, ma tutte le strutture, per quanto articolate che fossero, sono rimaste inutili o divenute inefficaci. La letteratura come rappresentazione della realtà e dell’immaginario è rimasta ai margini dei mezzi di comunicazione più usati, vuoi per la natura del media- e qui torneremo presto-, vuoi per la macchina ideologica che ha contrastato il pensiero divergente con una certa efficacia, attraverso una specie di rifeudalizzazione culturale più selvaggia di quella che si operava nella cosiddetta Prima Repubblica, dove valvassini e valvassori dell’etere e dell’editoria hanno contribuito in maniera considerevole alla produzione di una cultura allineata e, conseguentemente, all’attacco agli studi letterari. Alla base di questo processo di resa dei cervelli c’è sicuramente la fine delle grandi utopie e il rivelamento della funzione sacerdotale o ancillare di scrittori e filosofi a vantaggio delle dittature più sanguinose. Oppure c’è solamente una misteriosa tendenza ad allontanarsi dai fatti concreti, non solo perché non si crede più di poter cambiare la realtà con le parole, ma anche per una sorta di sottile masochismo o totale cecità.
Ma è più colpa del mezzo, del libro, ammazzato dalla televisione e dalle sue caratteristiche o più colpa della sconfitta degli intellettuali di fronte alla morte delle grandi utopie? Se consideriamo, in merito al media più tipico della letteratura, il libro, la teoria della dipendenza (vedi “Teoria delle comunicazioni di massa”, Bentivegna o un altro manuale analogo) ci chiarisce che «per la comprensione degli altri e del sé, ad esempio, i libri e la stampa periodica possono risultare maggiormente adatti di quanto non siano il cinema e la televisione». Sarebbe quindi la forma del libro e il modo in cui esso viene usato ad aver fatto a pezzi la letteratura, in un mondo dove la riflessione, in genere, non è contemplata nei processi di consumo e produzione. Conseguentemente, le grandi narrazioni si sarebbero spostate sugli scherni cinematografici e nuovi media, dove il prodotto si può consumare in altro modo? Difficile a dirsi. Ricordiamoci che l’Iliade veniva recitata e ascoltata collettivamente e che la fruizione della lettura è cambiata moltissimo nel tempo, senza inficiare il nocciolo duro della funzione letteraria per ogni contesto sociale. In questo senso, l’avvento degli ebook potrebbe tracciare, con un mutamento delle tecnologie, un’idea di lettura in community o una maggiore interazione con il testo, magari anche possibilità di modifica del prodotto durante la sua fruizione: su questo versante, potremmo essere alle soglie di una rivoluzione copernicana del modo di leggere. E, quindi, di una specie di scoperta della stampa, che darebbe una grande spinta alla diffusione di nuove idee e a cambiamenti epocali.
Dal punto di vista della funzione sociale dell’intellettuale umanista, specie del letterato, gli argomenti da affrontare sarebbero estremamente vasti. Sommariamente, potremmo fare, anche in questo caso, un’ipotesi, che parta da un dato di fatto. Il nostro sistema scolastico soffre ancora della propria matrice fascista, mentre l’università è un’oasi di baronaggio e prepotenze: sono innumerevoli i casi di cronaca e gli scandali in materia, mentre le risorse destinate ad alimentare questo stato di cose vanno scemando, anche a danno di precari, ricercatori e studenti. E la cosiddetta fuga dei cervelli, una vera e propria diaspora, non è in grado di certo di assorbire a pieno la carica intellettiva che le università rifiutano. Ora, se l’università non è più il luogo-tipo in cui fare cultura, se la televisione e i media ufficiali non lo sono altrettanto, dove viene elaborata quella riflessione genuina e autentica nei confronti della realtà, dell’immaginario collettivo e delle sue rappresentazioni? Probabilmente si va configurando all’interno di grandi organismi del terzo settore, all’interno di alcune fondazioni, nei think tank, anche se questi non sono sempre dei luoghi democratici. Più verosimilmente, la riflessione e lo studio letterario si fa su internet, su siti liberi e dai contenuti spiazzanti, tesi anche a distruggere i valori condivisi della nostra società: è il caso di Giap dei Wu Ming, di Carmilla on line, di Riserva Indiana e di altre piattaforme. A mancare, però, a questi consolidati esempi è forse la sistematicità scientifica di chi mantiene un dialogo vivo con la comunità accademica nazionale e ne corrode dall’interno il vecchiume. Forse, perché non c’è più nessun dialogo possibile e quel processo di osmosi con il mondo accademico che aprì la strada a gruppi più o meno integrati di intellettuali dissidenti non è replicabile in Italia. In pratica, fare menzione nei programmi di studio di letteratura contemporanea e, in generale, degli studi umanistici, del New Italian Epic è molto difficile- o almeno così appare- entro i confini della Repubblica, per quanto il dibattito sul genere ha coinvolto le università del mondo occidentale ed eminenti protagonisti del pensiero italiano, come Evangelisti o Asor Rosa.
A questo punto, bisognerebbe introdurre un ulteriore elemento, perché, se è vero che la riflessione online sulla letteratura tiene, non si può dire altrettanto della propensione a trattare sistematicamente i problemi pratici delle persone e ad elaborarli con la stessa potenza di fuoco di chi con i diseredati e le minoranze costruì un rapporto proficuo e sconvolgente. Insomma, se la gente non si interessa alla letteratura è anche colpa degli studiosi e del loro atteggiamento elitario, provvisto di deboli strumenti di divulgazione e poco intenzionato a dotarsene. Nella Birmingham del 1964 il professore Richard Hoggart fondava il CCCS- legato all’istituzione accademica ma con una certa indipendenza-, il centro da cui fiorirono i Cultural Studies, destinati a riscrivere l’interpretazione delle rappresentazioni della realtà e dell’immaginario. Gli strumenti che ci hanno dato studiosi come Hoggart o Hall oggi sono indispensabili per capire il mondo che ci circonda e la sua letteratura: si pensi all’encoding/decoding o al concetto di resistenza, che Willis elaborò nel suo lavoro a stretto contatto con i giovani della classe operaia (“Learning to Labor”). Da qui partì tutta una sequela di studi sulla differenza di genere (“Women take issue”) e sulle questioni razziali (There Ain’t No Black in the Union Jack”, Gilroy). Perché non prendere a modello il CCCS o anche una struttura totalmente esterna all’università, dove si possano unire gli sforzi e rimanere in contatto con i problemi del reale? Si dirà che questi studi del Centro di Birmingham sono quasi tutti non strettamente letterari e che con la produzione e l’analisi letteraria poco hanno a che fare. Ma quello che si vuole sottolineare qui è lo spirito che muoveva il lavoro dei Cultural Studies, nati in una sorta semiautonomia dall’università, cresciuti nel rapporto diretto con i famosi “problemi reali del Paese” e organizzati in maniera da creare un punto di riferimento per gli studiosi. Si dirà che l’approccio prevalentemente sociologico e cultorologico non si può esportare in un analogo centro umanistico generico, dove possano convivere letterati, filosofi, etc, all’insegna dell’interdisciplinarietà umanistica, figurarsi in un centro esclusivamente critico-letterario. Qui si potrebbe aprire una parentesi grande quanto tutto il demone del cosiddetto specialismo dei saperi, il quale certamente merita una contestazione meglio organizzata di quella qui accennata.
Il punto è che il contatto con il mondo e i suoi problemi può essere mantenuto da chi concepisce il suo ruolo come militanza attiva e abbraccia una missione sociale, di chi, in sostanza, continua a mantenere un rapporto con le sofferenze degli esseri umani e la salvaguardia dell’ambiente, ma deve essere organizzato e strutturato per resistere e controbattere alla devastazione dei centri di produzione di cultura in Italia. Anche perché, se i processi tecnologici hanno tolto egemonia alle cattedre, presto questa si condenserà altrove, esattamente allo stesso modo in cui questa traslò dai monasteri alle universitas durante il medioevo. E la letteratura, piuttosto che un fossile in bacheca, potrebbe essere uno strumento per migliorare le condizioni di vita delle persone, per mantenere un contatto con la forza dell’immaginazione e per scandagliare i sogni ad occhi aperti di un’umanità nevrotica. Non occorrono enfasi e retorica per parlare dello stato di cose presenti.
E, quindi, se da una parte lo studioso deve sicuramente sviluppare nuove capacità, che lo mettano più concretamente in stretto rapporto con la gente, dall’altra deve anche comprendere quali strumenti adoperare per avviarsi verso l’autonomia economica dai centri di potere e sotto quali regole organizzarsi. Fortunatamente, nostri letterati e umanisti non sono come i sapienti dell’accademia di Lagado, ma sicuramente i grandi sacerdoti del tempio sconsacrato della cultura gli assomigliano fortemente: professori, opinionisti televisivi, ingombranti editorialisti attempati, i loro lacché non sanno che cosa è un Neet, non parlano con i ragazzi di San Cristoforo e non hanno mai visto la base di Niscemi, ma continuano a fare da nocchieri a una nave che affonda. L’eredità di deserto che ci hanno lasciato, la pompa magna della loro lectio magistralis è smentita dal nostro bisogno primario di sopravvivere ai loro errori: come dice un altro Gulliver, quello de “Il sospetto” di Dürrenmatt, “Non dobbiamo salvare il mondo, dobbiamo cercare di sopravvivere, questa è l’unica avventura che ci sia consentita in questa tarda ora del mondo”. Sopravviviamo, quindi: non è un dovere, ma un bisogno.
di Giulio Pitroso
 ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.
ScenariGlobali.it Scenari globali, l'approfondimento in rete delle notizie di attualità politica,economica, culturale, sportiva ed altro.